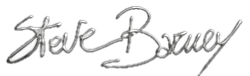QUANDE LE PARETI DIVENNERO PAVIMENTI
Tutti sappiamo che nella vita è importante scegliersi gli amici, e forse ancor più i nemici. Quanto agli amici di Stefano Bergamaschi, in arte Steve Barney, non posso pronunciarmi: sarei tacciabile di conflitto di interessi. Ma a proposito dei nemici, posso dire che Barney si è scelto bene i suoi. Fin dai primi passi ha individuato nella sua arte un’antagonista naturale -la Figura- e l’ha sfidata in duello all’arma bianca. Per “figura” intendiamo la ricezione calligrafica, ordinata, diligente del mondo esterno così come appare al nostro sguardo; l’idea corrente che il cosiddetto reale sia tutto ciò che c’è da rappresentare. Il Novecento ha raso al suolo questa convinzione, ma definire Barney come l’ennesimo espressionista, o astrattista, sarebbe necessario, ma non sufficiente. Nella sua opera la Figura è presente attraverso il massimo grado di rappresentazione realistica, ossia nell’immagine fotografica, e da questa rappresentazione nasce la sfida. Il duello c’è, è all’ultimo sangue, ma l’esito finale resta in bilico, delegato allo sguardo del visitatore.
Il percorso inizia negli anni Novanta, con la serie delle finestre di Venezia, istantanee carpite da Barney nei palazzi gentilizi ma anche nelle dimore più umili della capitale universale della pittura. Le finestre sono confini, passaggi segreti, l’emblema per eccellenza della transizione dal mondo esterno a quello interiore. A quelle finestre Barney si è affacciato, ha visto chi passava, e ha trattenuto tracce di chi più lo ha colpito. Picasso, Mondrian, Mirò, Pollock, Basquiat, Schifano… se ci sporgiamo da quei davanzali affacciati sulla dissoluzione della pittura figurativa, anche noi vedremo passare le loro ombre.
E dunque, quale esito può avere questo duello che si rinnova ogni volta che Barney mette sul cavalletto una tela, dalle finestre di Venezia alle icone femminili come Marilyn o Monna Lisa (il corpo femminile è anch’esso una finestra, una finestra sulla vita), fino all’ultima fatica, il ciclo dedicato al più famoso naufragio degli ultimi anni? Fasi alterne, esiti mai definitivi, perché il senso primario dell’arte di Barney, del suo sfidare a duello la Figura, non sta nel pensiero, ma nell’istinto.
“Leggere è vedere, scrivere è essere ciechi”, ha detto un grande critico letterario; allo stesso modo, esistono due categorie di pittori. I pittori che dipingono con gli occhi aperti, e la realtà la leggono, e i pittori che dipingono con gli occhi chiusi, e la realtà la scrivono. Steve Barney è in bilico tra i due emisferi, da lì deriva il senso di frattura tattile, di sdoppiamento emozionale, di furia vendicatrice emanante dalle sue opere. Prima Steve Barney vuol vedere al massimo grado, accosta la pupilla al telescopio. Con strumenti ottici più precisi dell’occhio umano va a caccia di epifanie come si va per funghi, giacché ogni vero artista è un cercatore di funghi. Come Pinocchio nel ventre della balena, si è calato nel fianco aperto della grande nave per arrivare fino all’occhio del ciclone, dove le pareti divennero pavimenti. Metacentro perduto, L’ultima ciambella, Ponte 1, Metaspazi, Fuoriasse, Squarci, Shining… con questi frammenti della memoria collettiva ha puntellato la sua visione; ma poi, in quel preciso momento, ha chiuso gli occhi e ha affondato il gesto nel buio dell’inconscio, nella profondità che si spezza ma non si spiega.
E’ ancora lui, il duello all’arma bianca con la Figura, che stavolta si carica di un contenuto nuovo; gli organi e le viscere del corpaccione inabissato, lettera e metafora di un naufragio che ci riguarda tutti, si potevano riportare alla luce solo attraverso la luce. Questo è da sempre il senso dell’arte di Steve Barney e anche delle venti scialuppe varate in questa mostra. Prendere il mare, alzare le vele, abbassare le palpebre e accogliere tutti noi. Un colore dopo l’altro, un gesto dopo l’altro, un turbine dopo l’altro, una carezza dopo l’altra. L’arte come promessa di rinascita, se non ancora di felicità. L’arte che cura e, forse, salva.
Nanni Delbecchi